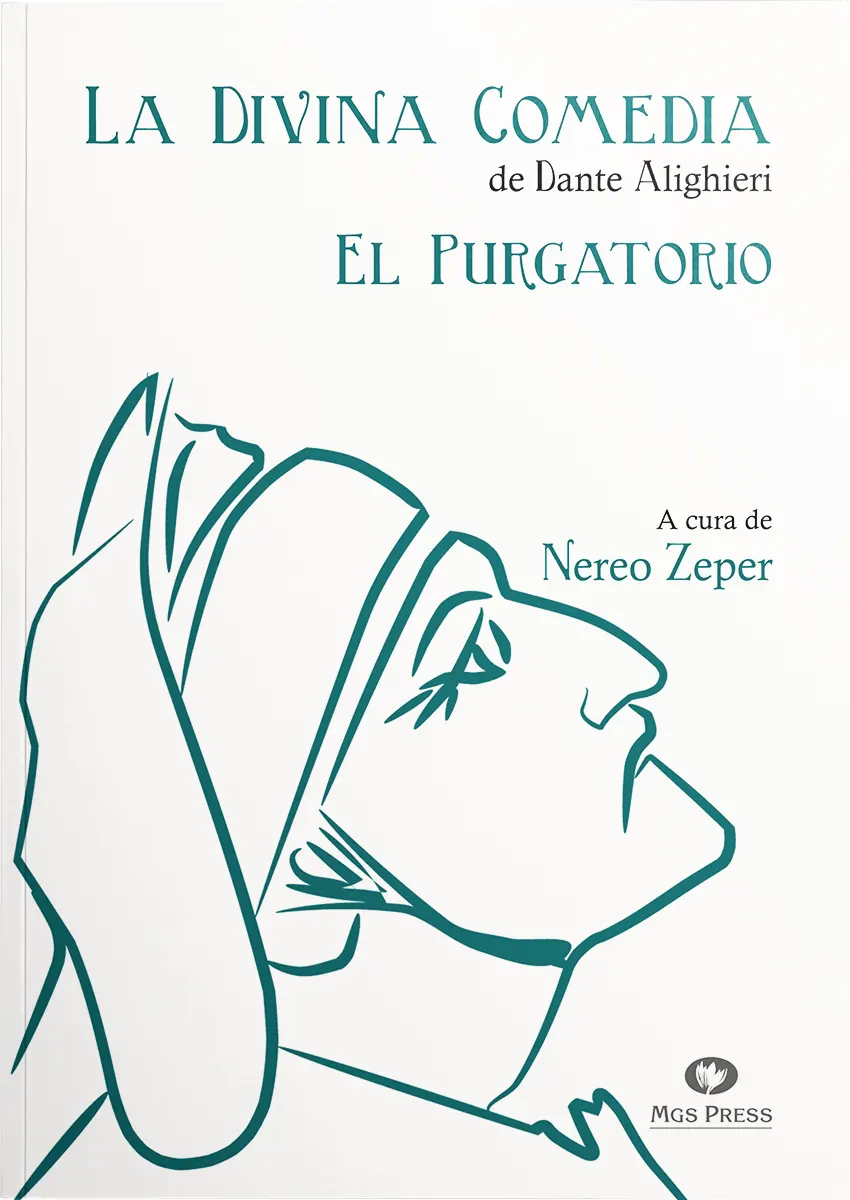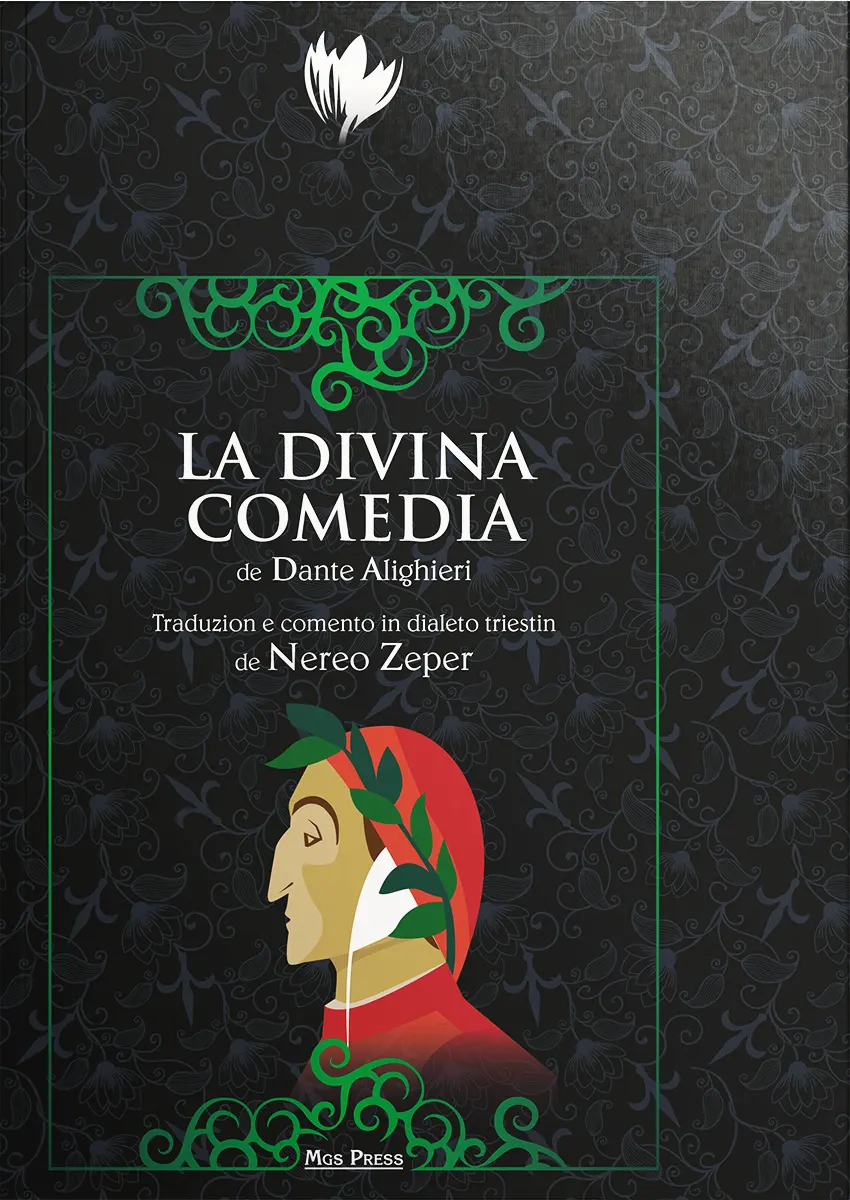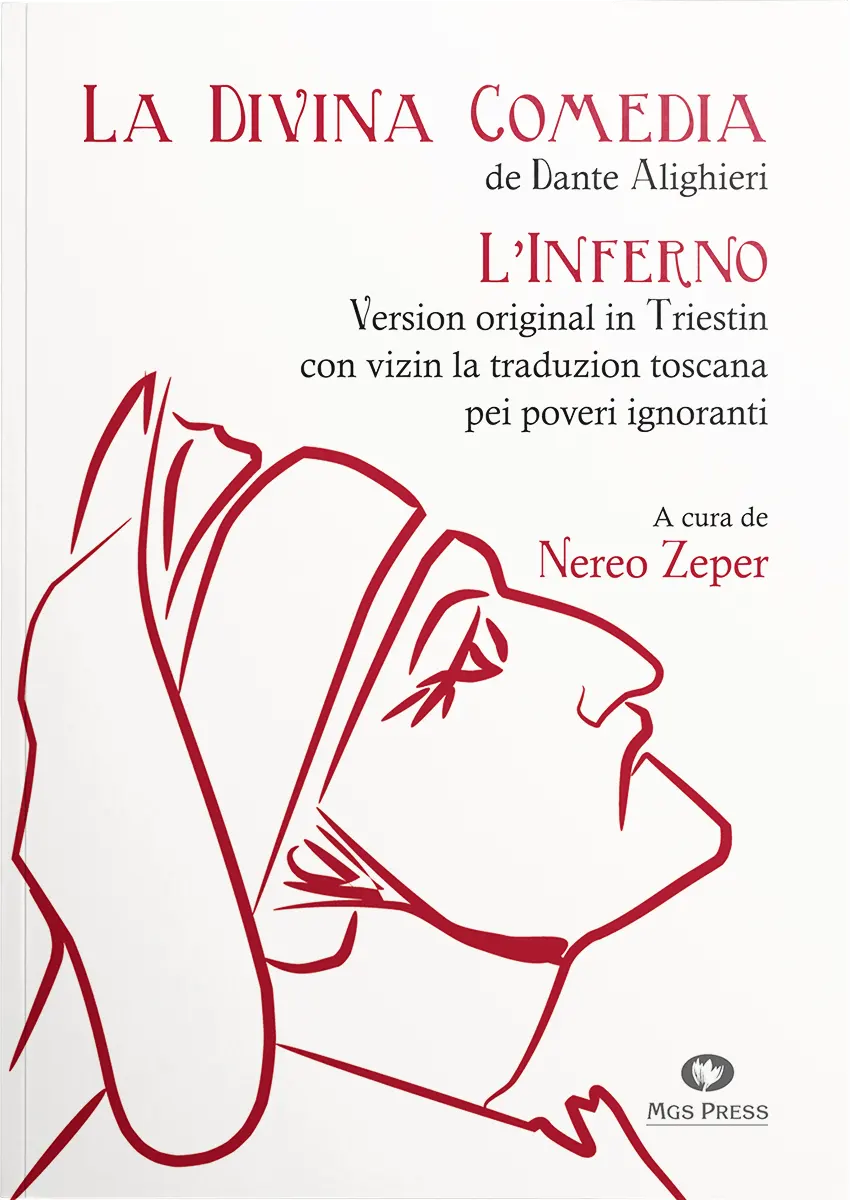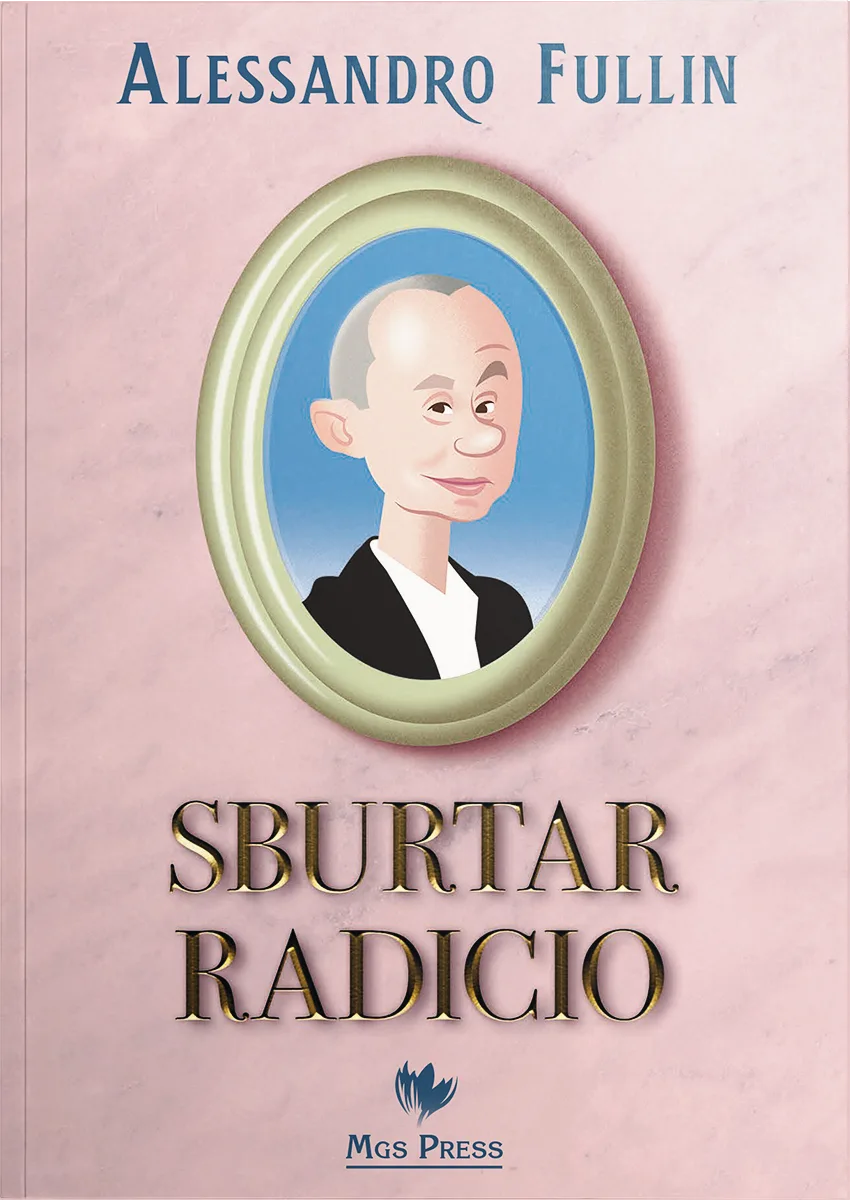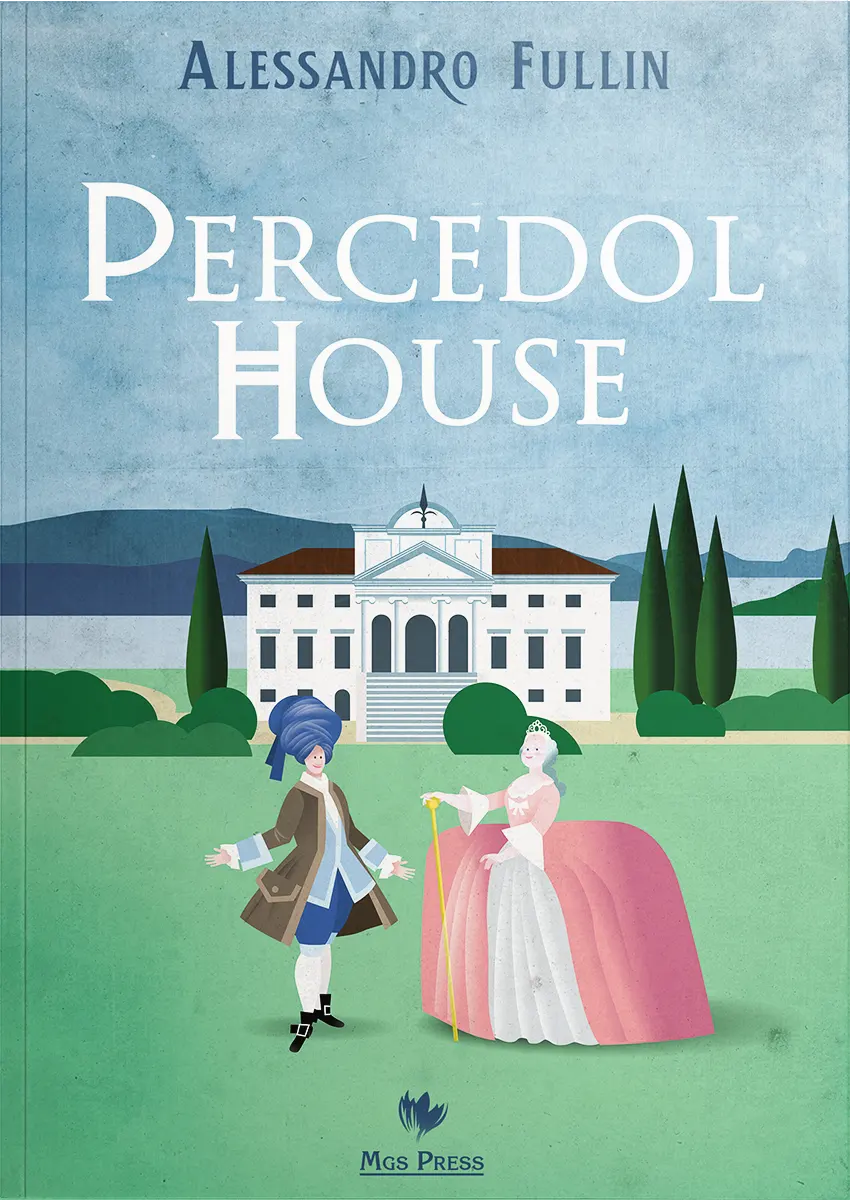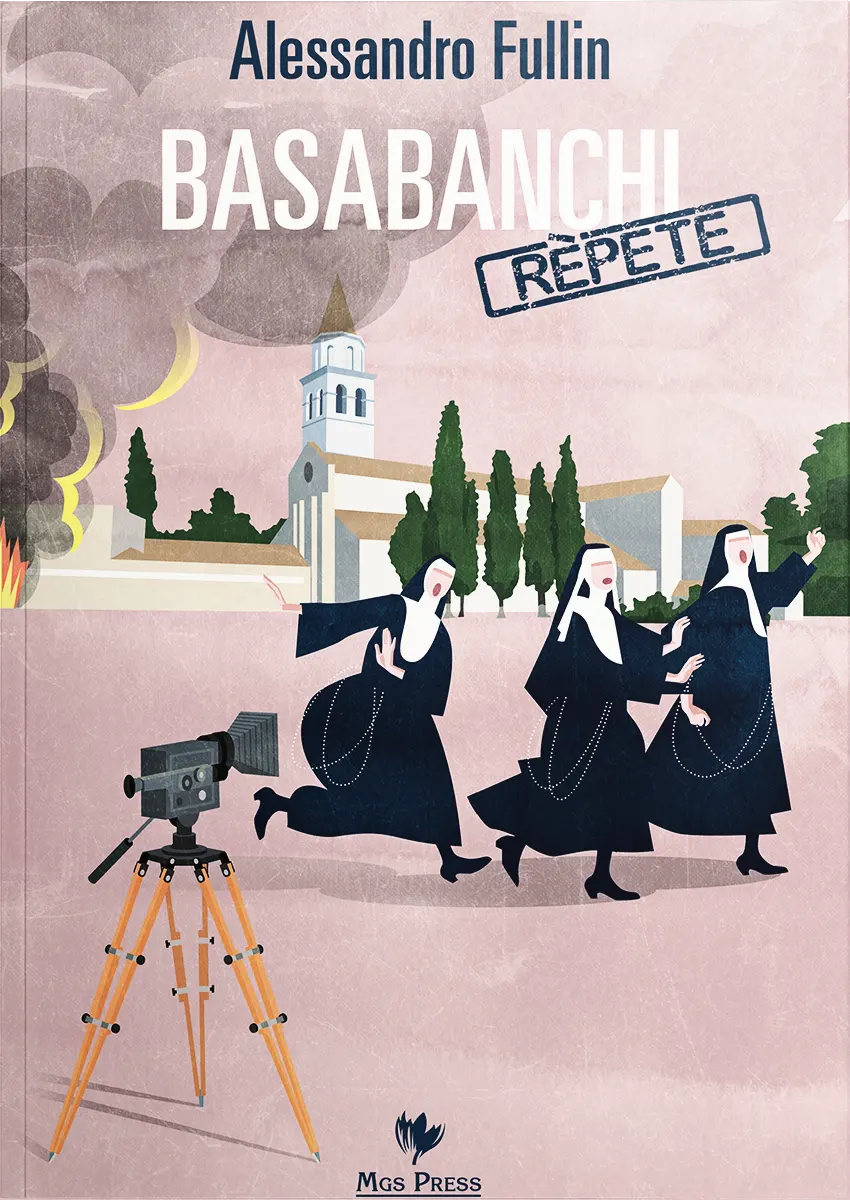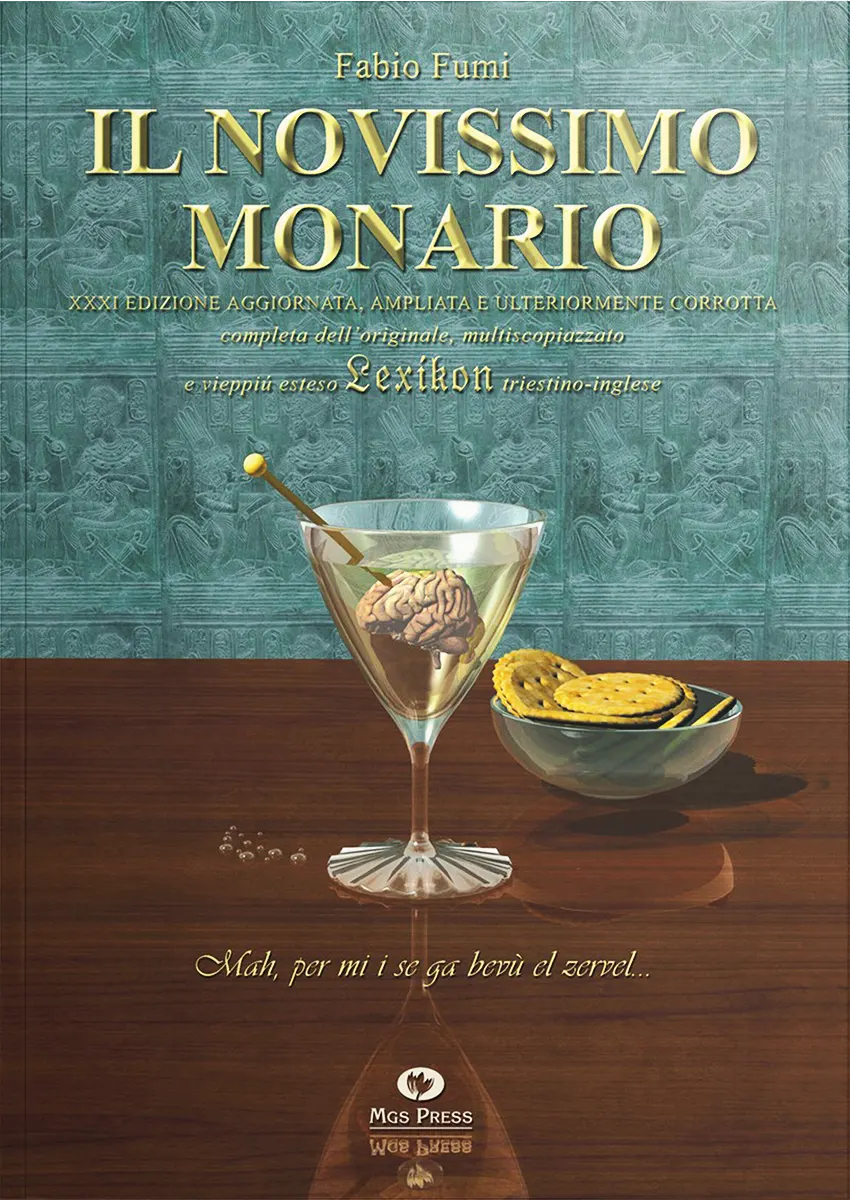C’è uno strano, presuntuoso e improponibile parallelismo – ma pure c’è – tra il volgare dantesco e il dialetto triestino di questa traduzione. Come il primo aveva alle spalle il latino che era la lingua alta, la lingua del pensiero e dell’arte, così il secondo ha alle spalle l’italiano, che per ogni triestino ha la stessa funzione. Come il primo era una lingua popolare che cercava di nobilitarsi affrontando argomenti che fino ad allora non erano stati mai sua prerogativa, così il secondo cerca di forzare l’ambito ristretto e talora persino plebeo dei significati di tante sue parole e locuzioni.
Certo Dante aveva a disposizione il toscano, lingua quant’altre mai ricca ed espressiva, e il traduttore di questo Purgatorio ha un triestino che è povero sia quanto al lessico sia quanto alla sintassi (pensiamo solo alla mancanza di pronomi relativi che non siano il misero). Ciò nonostante lo sforzo di nobilitarlo è stato compiuto e il campo semantico di tante voci – che al lettore non possono non suggerire ancora il tono greve dei parlanti più beceri – è stato allargato.
Forse questo lavoro non è che un tentativo di elevare il tono del triestino, forse è solo una prima spinta, ma il dialetto ha un disperato bisogno di recuperare la stima dei triestini – stima che un tempo aveva anche tra le persone colte – e di uscire dal campo ristretto del comico o peggio della canzonaccia da osteria. Ha bisogno d’amore e di fantasia e di parlanti che posseggano l’orgoglio di farlo sentire. E di scrittori che abbiano la faccia tosta di impiegarlo.